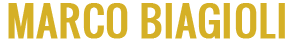Un viaggio offre immagini, storie, sensazioni ma è l’empatia che lo rende un’esperienza speciale e ricca. Così non ci sentiremo dei semplici spettatori ma intimamente protagonisti.
“Mettiti nei panni degli altri!” “No grazie, troppo difficoltoso e poi mi infastidiscono tutti quei comportamenti sbagliati”. È una situazione molto diffusa nella quale cadiamo spesso inconsciamente, così come facilmente sentiamo il bisogno di giudicare, forti dei nostri “valori” e di una presunta superiorità. Che dire poi del nostro inseguire modelli di successo falsi e inarrivabili per diventare, inconsapevolmente, sempre più soli ed egocentrici. Ormai non siamo più capaci di bilanciare il lavoro con il tempo libero, la produttività con gli affetti; così diventiamo facili prede del male del secolo: lo stress. Inoltre viviamo, come dice L Floridi, nell’infosfera laddove sono ormai irreversibilmente integrati l’aspetto fisico e quello digitale della realtà: immersi in una on-line experience.
Ma improvvisamente ci capita di fare un viaggio in terre lontane, ricco di momenti e ritmi speciali; allora è probabile che qualcosa cambi: possiamo riscoprire l’empatia, l’umanità. “La più grande scoperta della mia generazione è che gli esseri umani possono cambiare le loro vite cambiando le abitudini mentali” W James. Torniamo ad esistere, cioè ex sistere, venire fuori dall’ordinario, dalla vita come catena, dalla millenaria caverna, dove pure si è tenuti prigionieri, legati e con la faccia al muro ma stranamente felici di esserlo. Da gregari, inseriti nel gregge, a egregi (ex grege) fuori dal gregge. “Nessuno comprende quanto sia stupendo viaggiare finché non ritorna a casa ed appoggia la testa sul suo solito, vecchio e familiare cuscino” L Yutang.

Qui è facile incontrare persone verso le quali non dobbiamo corrispondere ad alcuna aspettativa, che condividono con noi l’intento del viaggio, la libertà di esplorare la novità. Ecco che nascono relazioni che non presuppongono un “dopo”, mentre con gli amici è diverso, c’è un pregresso, una storia. Si crea cioè una specie di bolla nella quale vive il gruppo, certamente con le sue incognite, ma dove prospera la voglia di un presente che dipende dalla capacità di stare insieme, di aggiustarsi sulle reciproche necessità, di non mollare nessuno. “Esigere molto da sé e poco dagli altri: ecco un mezzo per evitare ogni ostilità” Confucio.
Gli altri gettano su di noi uno sguardo completamente nuovo e ci consentono di vedere, riflessi nei loro occhi, aspetti di noi che possono sorprenderci, piacerci oppure no. “Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più di avere: l’estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t’aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti. “I Calvino. Gli altri percepiscono sensazioni, parole, pensieri che noi non pensavamo di possedere, anzi credevamo di offrire la parte brutta della nostra personalità. Invece ci aiutano a scoprire la parte bella, a capire che non sono cambiati loro ma noi stessi. “E’ una cosa divertente tornare a casa. Niente cambia, tutto sembra lo stesso anche gli odori. Realizzi che ciò che è cambiato sei tu” F S Fitzgerald.
Gli stereotipi si sgretolano, ci ascoltiamo meglio, cambia e si arricchisce l’idea che ognuno ha di sé in quanto viviamo in una nuova situazione, più libera, priva delle definizioni che ci proteggono, fuori dalla confort-zone. È come se ci si accorgesse di aver fatto un percorso che ci ha trasformato, fortificato, affinato l’intuito, sviluppato sensibilità e competenze nuove. E sembra che le persone che frequentiamo da sempre non ci riconoscano del tutto, mentre noi, a nostra volta, abbiamo la sensazione che siano rimaste in stand by e che sarà difficile sintonizzarsi di nuovo per comunicare. Diventa naturale “pensare” in una nuova lingua, guardare con occhi nuovi, percepire ed agire in modo diverso forti di nuove competenze. “Si viaggia non per cambiare luogo, ma idea” H A Taine.

Come comincia un viaggio? Stringendo in mano un biglietto carico di motivazioni, speranze, desideri e sogni, ma anche angosce, paure, incertezze. E spesso di micidiali aspettative che, con il loro coinvolgimento emotivo, ci fanno allontanare da noi stessi, desiderare il controllo, il cambiamento dell’altro, la pretesa di “far andar bene le cose”. Ci portano a credere che il modo in cui trattiamo le persone sarà esattamente lo stesso che riceveremo in ritorno. Sappiamo bene che non è così come ricorda D Pennac: “non c’è nulla che vada come previsto, è l’unica cosa che ci insegna il futuro quando diventa passato”. Pertanto meglio aprire la mente, tuffarsi in ogni esperienza senza nessuna pressione e aspettarsi, piuttosto, qualcosa da noi stessi. “Beato chi non si aspetta nulla dagli altri, perché non resterà mai deluso” A Pope.
Un viaggio, in qualunque posto, insieme a persone sconosciute accomunate dalla voglia di fare avventure nel mondo, è reso ancor più interessante dagli spostamenti con mezzi poco confortevoli. Lontano dalle rassicuranti (?) tribù virtuali dei social, senza la tranquillizzante (?) TV e senza il wi fi è normale entrare in una specie di solitudine, irrequietezza, originalità. Forse grazie a territori ignoti con foreste, laghi, deserti si tocca con mano il significato di un dato scientifico: chi vive in campagna ha il 40% di probabilità in meno di soffrire di disturbi dell’umore rispetto a chi risiede in città. Pressione arteriosa e livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, sono più bassi tra i non urbanizzati ed è molto meno attiva l’area cerebrale dell’amigdala, il centro biologico della paura. Se aggiungiamo la vicinanza fisica con i compagni di viaggio ecco che scompare la timidezza e si riacquisisce la capacità di parlare, sperimentare cose innoque e antiche ma potenti come dialogare e fare domande. Non le “domande assolute”, che non piacerebbero a L Floridi, ma domande aperte; quelle che iniziano con: come, cosa, descrivi, racconta. Sorprendentemente, durante l’ennesimo spostamento per raggiungere nuove tappe, può crescere e propagarsi spontaneamente un meccanismo virtuoso del tipo “io ti domando-tu mi rispondi”, come negli scompartimenti del treno prima dell’avvento dei cellulari o nelle sale d’attesa del medico.

In un lungo viaggio, oppure durante una vendemmia ed in altre occasioni è ancora possibile accostarsi, senza percepirla appieno, a quella che doveva essere la qualità della vita dei nostri genitori, oppure all’umanità di chi abitava nelle campagne dei primi del novecento e forse solamente immaginare l’intensità dei rapporti umani che doveva esistere nelle tribù. Ma non si pensi al villaggio africano! In realtà questa parola come tribuno, tributo, tribuna, tribunale deriva da tres bus buris ( tre aratri), rimanda alle tre gentes che fondarono Roma e indica: un gruppo relativamente omogeneo distaccato dagli altri” F Perussia.

Queste situazioni piene di apertura e accoglienza facilitano lo stabilirsi di relazioni, consentono di entrare in un mondo fatto di una fitta rete di conoscenze, dove è diffuso anche del sano pettegolezzo. Il che non significa elogiare la diffusione di voci dannose o storie imbarazzanti ma la condivisione di informazioni, fallimenti personali, rapporti difficili. Il pettegolezzo è un’arte che si insegna, come scrive R Dunbar. Certamente alcuni hanno paura dei pettegolezzi, chiusi nei propri vecchi schemi mentali e non sfruttano il contesto magico offerto da un lungo viaggio. “Il pettegolezzo è una forza della natura umana. Chi ha obbedito alla natura, trasmettendo un pettegolezzo, prova il sollievo esplosivo che accompagna il soddisfacimento di un bisogno primario diceva P Levi.
Questa parola in effetti ha una cattiva fama già dai tempi di Euripide: “le femmine per natura amano il biasimo se trovano un piccolo spunto per parlare, ne fanno un romanzo: le donne godono a parlar male l’una delle altre”. Eppure il termine gossip (god-sibb” cioè “god-sibling” il parente che fa da tutore al bambino per il battesimo) rimanda ad una delle più antiche istituzioni sociali: al grooming. Il caratteristico spulciarsi a vicenda praticato dai primi ominidi che consentiva di imparare a distinguere gli amici dai nemici, creare legami sociali, dimostrare fiducia. Tant’è che l’essere esclusi dal giro non era un buon segno, significava non essere accettati dal gruppo. Successivamente il linguaggio ha consentito di identificare le relazioni di potere interne al gruppo grazie alle “dicerie” che percorrevano la comunità, ovvero di superare il livello base di sopravvivenza, cioè sapere dove erano i leoni o i bisonti. Infatti molto più importante era:” sapere chi, nel loro gruppo, odia chi, chi dorme con chi, chi è onesto e chi è un imbroglione” Y Harari. Ed ancora di più era dare origine alle creazioni sociali umane mediante la capacità di raccontare storie e convincere gli altri a credere ad una realtà immaginata sempre più ricca e potente.
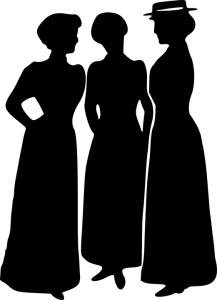
Quindi riabilitiamo il pettegolezzo buono. “Quell’istinto umano fondamentale; perché le nostre vite sono profondamente radicate in gruppi… ma dipendiamo anche dalle persone nei nostri gruppi per sopravvivere… “ come dice M Leary. In tali contesti anche il timido si concede di esplorare il nuovo. Questo grande osservatore, che aspetta prima di parlare per evitare fraintendimenti, che è anche un bravo ascoltatore, così gentile agli occhi degli altri, può aprirsi ed affrontare una piccolissima dose di imbarazzo per scoprire che quel piccolo disagio gli è servito per imparare ad immunizzarsi come Mitridate. A comprendere cioè che essersi sottoposto volontariamente ad una piccola dose di “veleno”, del tipo vinci facile, come una domanda al coordinatore, lo ha gratificato, gli ha consentito di scoprire come mantenere l’autocontrollo.
In questo “spazio nuovo” del pulmino magico, si crea un’atmosfera in cui il tutto è superiore alla semplice somma delle parti; un clima di dialogo e scambio, nel quale ciò che l’altro “porta” diventa facilmente proprio. Un bell’ambiente dove regna reciprocità, serenità, scambievolezza, confronto e tutti sono allo stesso modo protagonisti nel loro semplice ruolo di viaggiatori. Vi è un sentimento di appartenenza in cui nessuno giudica o ha paura del giudizio altrui e si sviluppano appoggio e cooperazione. Nessuno è obbligato a parlare, ma, se sollecitato dal coordinatore, saprà fare una domanda a chiunque nel clima “vinci facile” e ritrovarsi gratificato.
“Il regalo più prezioso che possiamo fare agli altri è la nostra presenza. Quando la nostra attenzione abbraccia le persone che amiamo, esse sbocciano come fiori” T N Hanh. In Danimarca l’insegnamento dell’empatia è obbligatorio per far fronte ai problemi imposti dalla tecnologia. Siamo infatti abituati a ricevere una quantità di stimoli superiore a quella che possiamo gestire e perdiamo in umanità. È dimostrato come gli studenti di oggi siano il 40% meno empatici degli studenti anni 80/90. Allora riabituiamoci, a piccole dosi, all’ascolto, alla sospensione del giudizio, a trascorrere più tempo con persone diverse, leggere, insegnare. Viaggiare!

Durante il viaggio ci sono molte occasioni per perdere sé stessi ma molto importanti per trovare sé stessi. In cima ad una torre, davanti alla Gioconda, durante la cerimonia del tè in Giappone, piano piano ci si fonde con tutto quello che ci circonda. I pensieri rallentano fino a diventare pure sensazioni. Viaggiare genera empatia, magari grazie all’aiuto offerto ad uno sconosciuto, una buona indicazione, un gesto di comprensione in un momento di disperazione o un’invito a cena in famiglia. Questi potenti fattori di cambiamento fanno comprendere la dannosità del giudizio a favore della comprensione e dell’aiuto disinteressato; che siamo tutti diversi ma tutti uguali nel nostro essere umani. Che anche un sorriso, un suggerimento, quando richiesto, o un semplice “grazie” possono dare una svolta positiva ad un’altra persona! Ricordiamoci che in tibetano la definizione di “essere umano” è a-Go ba, “viandante”, “chi fa migrazioni” B Chatwin.