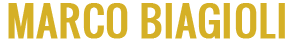“Il mio primo ricordo? La noia nel passeggino blu davanti ad un video. Per mio figlio desidero altro, ma il cellulare mi è sempre utile: lo faccio vedere al cane così sta buono”.
Come fa un gatto a diventare un vero gatto? E un neonato a diventare un vero uomo? Per aprire il dibattito ecco due frasi, una di M Levine: “Avere bambini non ti rende un genitore più di quanto avere un piano non faccia di te un pianista” e una di M Badiale: “non è vero che serve un uomo per fare di un bambino un adulto. È vero soltanto che serve un bambino per fare di un adulto un uomo”.

I primi anni di vita sono tra i più importanti nello sviluppo del sistema mente-corpo in quanto avviene oltre l’80% dello sviluppo neuronale grazie agli stimoli mentali ed alle interazioni umane (giochi, dialoghi, passeggiate, corse, profumi, colori). Lo sviluppo mentale, dice J Piaget, è una costruzione continua, paragonabile a quella di un vasto edificio che ad ogni aggiunta divenga più solido, o piuttosto alla messa a punto di un delicato meccanismo. “ … Non solo le neuroscienze, ma più di seimila studi sull’attaccamento, che hanno seguito i bambini dalla nascita all’età adulta, dimostrano con certezza che le esperienze vissute nei primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo …”. G Proietti.

L’apprendimento e lo sviluppo infantile non sono qualcosa che capita ma richiedono un’attenzione costante. “Quanto più una cosa è nobile e perfetta, tanto più tardi e più lentamente giunge alla maturità”. A Shopenhauer. É un’attività faticosa che molti genitori alleggeriscono, a volte, dando il tablet in mano ai bambini, quando devono riordinare la casa, per calmarli, per addormentarli, distrarli ovvero cenare in tranquillità. Magari si giustificano dicendo che l’incontro con le nuove tecnologie deve avvenire al più presto per non trovarsi impreparati, quando invece ciò non produce automaticamente competenze. Direbbe G Bufalino: “Conviene a chi nasce molta oculatezza nella scelta del luogo, dell’anno, dei genitori”.
Il modo in cui trattiamo i figli condizionerà il modo con il quale verrà loro istintivo trattare il mondo. È la propria infanzia a determinare il nostro modo di affrontare il successo ed il fallimento dice H Ramis. Abbastanza inquietante è quanto successo ad una bambina di un anno, abituata ad usare il tablet, alla quale è stata data una rivista; ebbene ha cercato di usarla allo stesso modo. ”Ci sono tre modi per rovinare una società: con le donne, che è il più comodo; con il gioco, che è il più veloce; coi computer, che è il più sicuro”. O Dreyer-Eimbcke.

Il bambino che passa troppo tempo in balia dei videogiochi rischia di ritrovarsi con un cervello simile a quello dei giocatori d’azzardo a causa dell’aumento di quella porzione che regola la ricompensa. La più ricca in dopamina, con l’effetto di sviluppare, oltre la dipendenza, una smaniosa voglia di competere e vincere. È vero che i videogiochi li rendono più rapidi nel prendere decisioni e nella gestione dei rischi, in quanto, pur senza esporsi al pericolo reale, si trovano svariate volte nella posizione di dover agire in fretta per raggiungere un obiettivo. Ma attenzione agli effetti negativi, il multi tasking può ostacolare la concentrazione e portarli a un pensiero più superficiale … e a scarsa motivazione nel fare i compiti.

Inoltre questa riduzione del tempo di elaborazione degli stimoli, necessario affinché si verifichi un buon apprendimento e la concomitante facile distrazione cui l’individuo è indotto dall’interferenza continua dei molteplici elementi presenti su uno schermo, possono portare, se estremizzati, alla “demenza digitale”. Un’espressione usata da Spitzer per riferirsi alla sindrome individuata in Corea del Sud, paese ad alta diffusione di tecnologia informatica, che colpisce i giovani dediti all’uso dei media digitali per molte ore al giorno e caratterizzata da appiattimento emotivo, isolamento, difficoltà di attenzione e di memoria e un generale declino delle capacità di apprendimento. “Abbiamo nella testa un computer straordinariamente potente, non troppo veloce”. D Kahneman.

Il concetto di fondo è semplice: la “profondità di codifica” cioè la complessità dell’elaborazione cognitiva cui sottoponiamo uno stimolo influenza la solidità dei nostri apprendimenti, nel senso che più ci soffermiamo e riflettiamo attivamente su un elemento da apprendere, maggiore sarà la probabilità di ricordarlo a lungo termine. Per crescere bambini e ragazzi “hanno bisogno del mondo intero e non di una sua scialba riproduzione digitale”. Spitzer. Vi è poi nelle nuove generazioni un: ”bisogno di gratificazione istantanea di risposte che la tecnologia ha insinuato nei suoi utenti … Oggi è sempre più difficile che i bambini leggano. La lettura non promette piaceri immediati come la TV, i videogiochi e il Web”. M Ranieri.
I cosiddetti nativi digitali (o forse ignoranti digitali esperti di copia e incolla) vedono pure modificarsi la capacità di riconoscere e sperimentare le emozioni, con due importanti effetti: da un lato le emozioni provate durante la fruizione di molti contenuti mediali sono “disincarnate”, sono “nel mio corpo ma non vengono dal mio corpo” dall’altro, prevalendo le relazioni mediate rispetto a quelle dirette, ne consegue un alto livello di analfabetismo emotivo. “Ci sono due tragedie nella vita. Una è invecchiare, l’altra non essere mai stati bambini”. M Badiale. Una ricerca dice che un bambino di 4 anni ride 4000 volte al giorno, ricorda Morelli; un adulto di 40 anni ride 40 volte in ogni circostanza. Siamo diventati troppo artificiali, troppo paurosi di stare con noi stessi.

Invece di demonizzare la tecnologia gli adulti dovrebbero incuriosirsi e fare domande, dice Mazzucchelli, cercando per esempio di capire perché piace un determinato videogioco, quali emozioni procura, quali sono le regole del mondo virtuale, perché ci si affeziona più a un personaggio che a un altro e così via. In questo modo si verrebbe a creare un ponte sul quale possono passare non solo informazioni su tecnologia e videogiochi, ma anche concetti comportamentali, valori, norme e suggerimenti che devono sempre essere bidirezionali: l’insegnante (o il genitore) al ragazzo, il ragazzo all’insegnante”.
Ecco alcune domande da porre al bambino perché cominci a riflettere criticamente e diventare più consapevole di cosa fa e di come gioca: “come ti fa sentire questo videogioco? Cosa ti propone di fare? Quali abilità richiede? Ti senti rappresentato da quel personaggio? Cosa vorresti cambiare di questo videogioco?”. Altrimenti il rischio, dice M Recalcati, è quello di rendere lo schermo del proprio pc uno specchio vuoto che, anziché aprire mondi, li richiude in un’auto referenzialità mortifera”.
I genitori dovrebbero offrire una “dieta digitale” più equilibrata con cui “nutrire” i nativi digitali agendo sulla qualità e la quantità dei “cibi mediatici” e costruire relazioni dal vivo, non solo su internet, usando la tecnologia come pretesto relazionale. “Secondo la mia teoria, tutti quelli che fanno parte dello show business sono stati da bambini trascurati” R Romano. L’ambiente deve essere ricco di motivi di interesse, dice M Montessori, che si prestano ad attività e invitano il bambino a condurre le proprie esperienze. Probabilmente la frase che racchiude meglio il suo concetto di educazione è:” Aiutami a fare da solo”.

La potente accelerazione degli ultimi decenni con la tv nel dopo guerra, computer e videogiochi negli anni 80, internet nel 1999, i cellulari nel 1990, i tablets nel 2000, smatphones nel 2006 ha introdotto nuove discussioni rispetto alla preoccupazione espressa dal Socrate platonico. Ovvero che la diffusione della scrittura avrebbe creato un falso sapere e diminuito la memoria dell’uomo in quanto “morto discorso” rispetto alla parola pronunciata, viva, ricca di entità dinamiche e di significato. Seppure, secondo Vigotszky, se fosse vissuto anche solo una generazione più tardi, il suo atteggiamento sarebbe stato più clemente.
Dice Rodotà che la tecnologia “libera la vita da antiche schiavitù, quelle dello spazio e del tempo, e questo è già realtà per milioni di persone. Internet non è soltanto il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto. È un luogo dove la vita cambia qualità e colore, dove sono possibili l’anonimato e la moltiplicazione delle identità, la conoscenza e l’ubiquità, la libertà piena e il controllo totale. In rete ognuno può essere davvero “uno nessuno e centomila”, come diceva Pirandello. Ma: “La tecnologia ci dice come fare certe operazioni. È muta davanti al perché”. Ferrarotti.

”Nessuna epoca storica, per quanto assolutistica o dittatoriale, ha conosciuto un simile processo di massificazione, perché nessun sovrano assoluto e nessun dittatore era in grado di creare un sistema di condizioni d’esistenza tali dove l’omologazione fosse l’unica possibilità vita”. U Galimberti. Dice G Nardone che l’unica conoscenza che può renderci liberi è quella che riguarda noi stessi e l’umanità. Una conoscenza che non è mai solo intellettuale ma soprattutto esperenziale. È la mia interazione con la realtà che, cambiando la realtà, me la fa conoscere. È un cambiare per conoscere che vale anche con noi stessi: io conosco quello che sono e come funziono se mi metto alla prova. Se voglio imparare è mentre imparo a fare una cosa che comprendo quanto sono in grado di impararla e non se penso di impararla. In sostanza si conosce il mondo attraverso palloni sonda che rimandano indietro conoscenze su cui aggiustare il tiro fino a raggiungere l’obiettivo.

“Esistere significa cambiare, cambiare significa maturare, maturare significa continuare a creare sé stessi incessantemente”. H L Bergson.